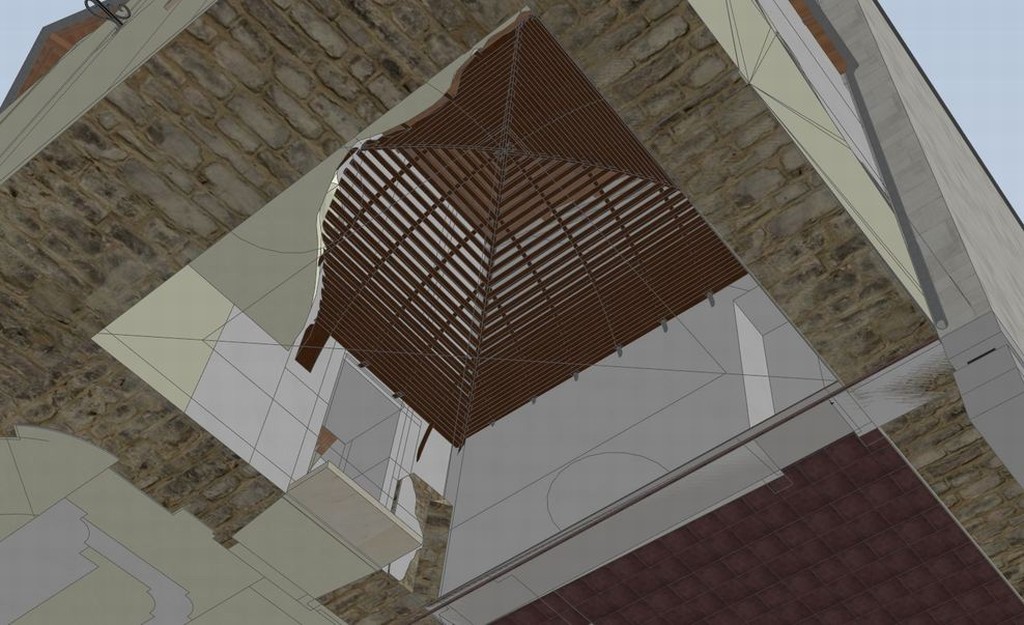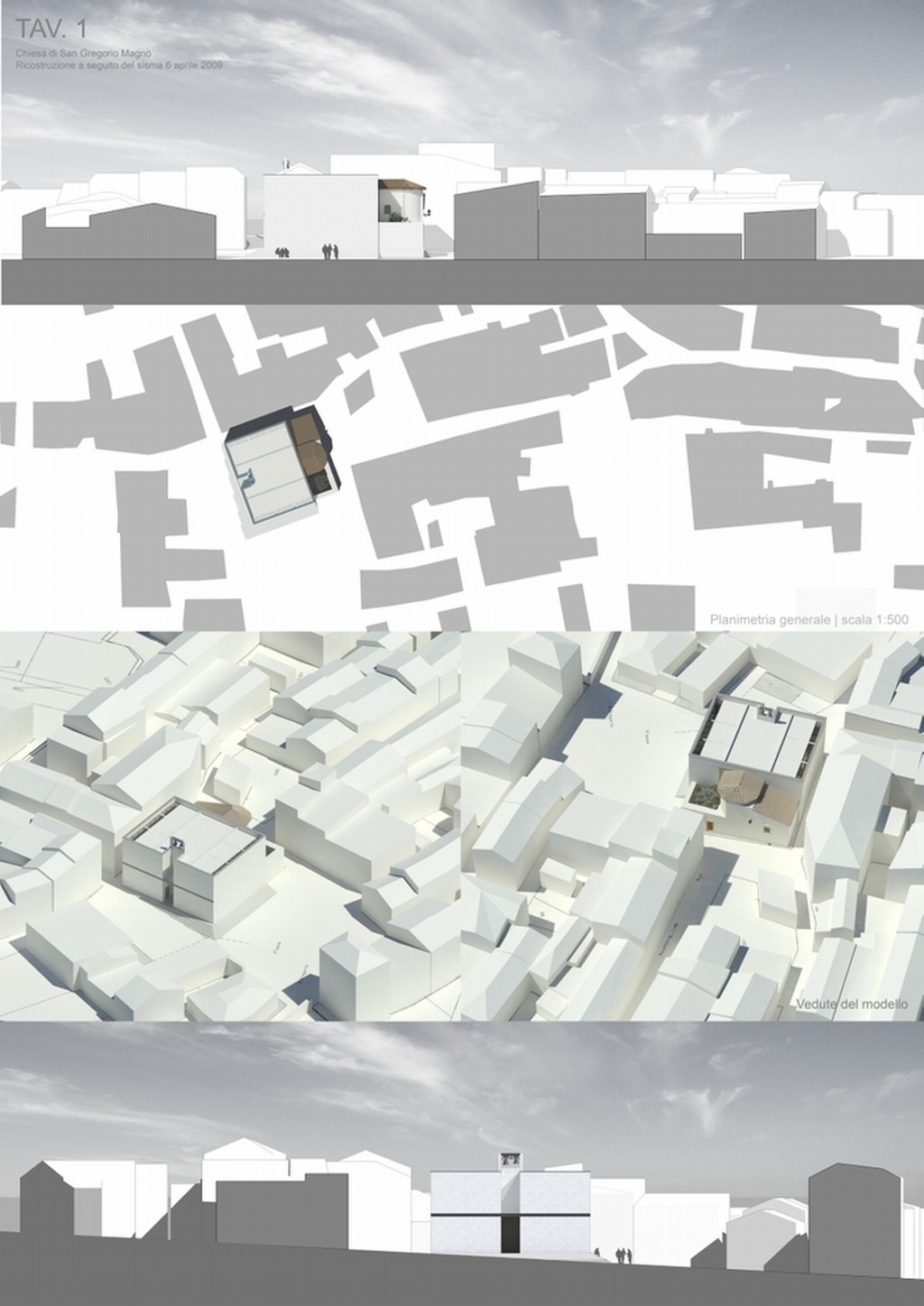Restauro chiesa di San Gregorio Magno. L'Aquila
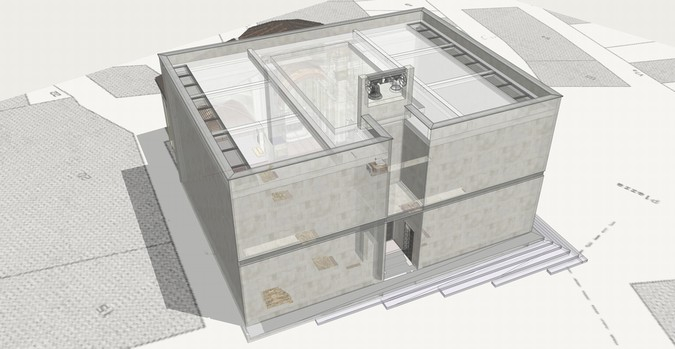
A nostro parere solo il come della ricostruzione, cioè solo una proposta concreta, è in grado di
spiegare senza equivoci la ragione di essere della ricostruzione, il suo perché.
Ma, per prima cosa, nel dare sostegno ad ogni pratica, ci siamo posti il problema della opportunità
della ricostruzione della chiesa di San Gregorio Magno, a partire dai dati razionali del programma
di concorso, ma anche dalle motivazioni più generali, dalle aspettative ecc., consapevoli peraltro del
fatto che, secondo noi, l’architettura è in grado di rispondere solo a determinate domande.
La nostra conclusione è stata che la ricostruzione della chiesa avrebbe senso solo se riuscisse a
trovare un convincente equilibrio fra le diverse componenti e i valori in gioco, in particolare un
convincente equilibrio, sul piano della risposta architettonica, fra quello che rimane della vecchia
chiesa, e la sua parte da ricostruire.
A questo punto dobbiamo dire che cosa intendiamo per ricostruzione, quello che deve essere,
secondo il nostro giudizio, una ricostruzione.
Per noi ricostruire vuol dire costruire (non c’è differenza se non cronologica). Ricostruire la chiesa
di San Gregorio Magno, vuol dire costruirla dov’era e com’era senza alterazioni o deviazioni ossia
senza imporre tortuosi percorsi interpretativi, ma anche costruirla con i nostri occhi, cioè come la
vediamo noi oggi e con i mezzi espressivi e tecnici di cui disponiamo. Una chiesa, dunque, che
mette di nuovo alla prova, anche, la sua forma. La forma, quella della nuova chiesa, che
orgogliosamente vuole ripetere i suoi vecchi segnali di riconoscimento, l’aula come il luogo della
assemblea e il presbiterio come luogo in cui si celebra il rito. Fra questi due luoghi va stabilita una
relazione aperta, non di separazione fra due realtà diverse, ma di rapporto stretto.
Questo è il motivo per cui, la nuova aula, definita su tre lati e aperta sul quarto, accoglie, quasi
amorevolmente a sè, i due frammenti conservati delle pareti della vecchia aula, come un abbraccio
alla vita nascente, aprendosi sul fronte in rovina del presbiterio, lì dove si conclude l’azione
liturgica. Nel progetto questo luogo ci appare come l’unico fondale possibile.
Il fronte principale dell’aula è caratterizzato da un profondo taglio verticale che attraversa tutta la
facciata, interrotto orizzontalmente da una putrella in ferro formando una grande croce. Il disegno
che così appare, rimanda idealmente al mistero della porta-croce: “Io sono la porta delle pecore…Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Giovanni,
10, 7.9). I tagli presenti in copertura sono, in realtà, due linee di luce formate da due lucernari che
attraversano l’intero edificio e accompagnano il fedele fino all’altare là dove è custodito il
Santissimo Sacramento. La pietra che segna la pavimentazione interna traccia il disegno della
vecchia chiesa come uno schizzo in pianta su un foglio di carta.
E poi la particolare ricostruzione della volta del presbiterio (come anche quella della sagrestia), che
ridefinisce la sagoma originale attraverso una struttura lignea di centine, sagomata secondo le curve
ricavate dalle sezioni verticali. Questo approccio permette la lettura contemporanea degli interventi,
guardando le murature come in una sezione e al contempo di evidenziare il dramma della
distruzione. La struttura lignea recepisce l’ordine strutturale delle volte preesistenti. L’arco in legno
lamellare copre la larghezza di 3,65 mt. ed integra, la residua struttura in mattoni, opportunamente
consolidata. Il restauro lascia leggere ogni fase costruttiva e funzionale, lascia intuire il drammatico
evento con i segni astratti del disegno architettonico e l'enfatizzazione scenografica di punti di vista
privilegiati. Anche le aggiunte si stratificano, in modo chiaro ma sempre reversibile.
L'accostamento del vecchio con il nuovo è il tema costante del restauro, ma nel nostro caso trova
modo di arricchirsi con interventi che tendono verso i modi propri dell’allestimento, quindi parlano
il linguaggio non della discontinuità tra antico e nuovo, ma quello della “provvisorietà”. Come se
solo il tempo e lo scorrere della vita potessero dare le certezze necessarie per conseguire un esito
veramente “definitivo”.
Su un lato del presbiterio la sagrestia, li dov’era com’era. Sulla parete che la divide dall’aula, il
coro. Una soluzione costruttiva rivestita interamente in legno, e che vuole avvertire l’opportunità di
adeguarsi e distinguersi dalla costruzione originale proprio nel suo adattarsi alla rovina senza
confondersi. Sull’altro lato dove c’era la cappella con coro, andata completamente distrutta, una
piccola aula senza soffitto che ci piace denominare, “Il vuoto della memoria”. D’altronde, l’origine
del termine “aula” comprende il significato di “dimorare all’aria aperta”, di “recinto senza soffitto”.
Abbiamo voluto cioè che anche nella forma di questa parte del vecchio restasse alla fine impresso
anche il segno della trasformazione, del cambiamento, che è come dire il segno della distruzione
insieme a quello della ricostruzione. Al centro, sulla terra battuta, una pianta di olivo, simbolo di
pace ma anche della rigenerazione, dove vi si potrà celebrare, anche, il rito del ritrovarsi e del
rinnovarsi, per non dimenticare.
E questa, noi crediamo sia, la vera forma della chiesa di San Gregorio, cioè quella forma che
restituisce, senza allontanarsene, la sua ragione storica, incluso naturalmente l’oggi.
La struttura del nuovo edificio
La scelta progettuale di carattere strutturale del nuovo edificio è basata sull’utilizzo della muratura a
sacco armata, reinterpretando quindi in chiave moderna l’aspetto formale di una tecnica muraria
antica. In tale occasione, la muratura a sacco armata è costituita da due pareti di pietra bianca “Perla
d’Abruzzo” (estratta da una cava sita in Loc. Vigliano. AQ), poste a una distanza di 39 cm,
collegate mediante staffe di ferro piatto a C connesse alla facciata superiore delle pietre mediante
fori e resina epossidica, distribuite uniformemente nel numero minimo di 4 ogni metro quadrato.
Particolarmente interessante è la libertà nella disposizione compositiva permettendo interventi,
come nel nostro caso, caratterizzati da una particolare complessità spaziale.
Interventi di conservazione e consolidamento
1. Premessa.
Il progetto di restauro qui di seguito descritto è relativo alla ricostruzione e al consolidamento dei
resti della Chiesa di San Gregorio Magno, sita nella Frazione di San Gregorio (AQ), gravemente
danneggiata e parzialmente distrutta dopo l’evento sismico dell’aprile del 2009. Il progetto si basa
innanzitutto su principi quali rigore filologico rispetto all’esistente, e grande attenzione all’uso dei
materiali e delle tecniche costruttive, per la salvaguardia del monumento. In particolare, la scelta dei
materiali da impiegarsi è basata sui principi di compatibilità con quanto esistente in loco,
reversibilità, efficacia nel tempo e non alterabilità, come anche le tecniche costruttive scelte che
devono necessariamente integrarsi con quelle impiegate per la realizzazione dell’edificio oggi
semidistrutto.
Ciò che preme rimarcare fin da subito è come sia spesso infausto l’esito di restauri eseguiti con la
perdita della coscienza e della conoscenza relativa ai materiali e alle tecniche e tecnologie
costruttive che lo stesso manufatto architettonico ci riporta, interventi che non considerano
l’incompatibilità che può derivare dall’impiego di materiali e tecniche costruttive troppo differenti
da quelli iniziali. Trascurare questo aspetto può comportare danni notevoli in sede di intervento,
mentre una metodologia deve accordarsi con l’oggetto architettonico esistente, sia nella forma, nella
composizione degli elementi, nella tecnica e tecnologia costruttiva, nei materiali. Ciò consente di
controllare la mano del progettista, che nell’intervento su di un bene architettonico già esistente è
comunque tenuto a confrontarsi con ciò che tale bene rappresenta, ipotizzando un recupero
rispettoso del contesto e della cultura del manufatto e ragionando su come conservare l’esistente,
inglobandolo per necessità ma non nascondendolo all’interno del nuovo intervento.
Si sottolinea, inoltre, come molte volte si ritiene di maggiore utilità l’apprendimento delle più
aggiornate tecniche e tecnologie di intervento, considerate garanti di qualità e buona riuscita di un
progetto di restauro, senza prestare importanza alla logica secondo la quale queste debbano trovare
applicazione. In virtù di tale valutazione, è doveroso precisare che: se il metodo può trovare
applicazione quasi universale, ogni manufatto e ogni materiale é un problema a sé stante ed è
indispensabile conoscere il comportamento delle componenti costituenti, soprattutto nel caso
dell’aggiunta di elementi ex novo come in questo caso.
E’ chiaro che nessun intervento progettuale servirebbe a restituire l’immagine originaria del
manufatto, data l’impossibilità di recuperare sia il contesto storico, sia i materiali - pur con la
possibilità di attingere alle macerie presenti in cui recuperare materiale di recupero da costruzione -
e le caratteristiche delle finiture. Tuttavia, è necessario e fondamentale ridare al manufatto la
medesima dignità originaria nel contesto attuale, un hic et nunc da tramandare al domani nelle
forme che oggi vediamo, seppur nella loro esiguità, ma portatrici ancora di tutti quei segni che ne
raccontano la storia.
Considerata questa premessa, le linee guida del progetto sono:
a) la conservazione dei segni, dei materiali e delle tecniche costruttive ancora leggibili attraverso le
testimonianze materiche presenti in loco, in modo da preservare nel miglior modo possibile la facies
originaria del monumento, nonostante siano da affrontare gravi problemi di instabilità strutturale e
da eseguirsi importanti ricostruzioni murarie;
b) la reversibilità degli interventi progettati e l’utilizzo di materiali compatibili fra loro e con quelli
originari;
c) interventi e integrazioni distinguibili dagli elementi originali: se il reintegro è necessario per
ricreare l’unità formale e strutturale, tuttavia si vogliono evitare effetti di mimesi tra gli elementi
nuovi e quelli originari ancora presenti in loco.
Tale premessa vuole mettere in risalto che la scelta delle metodologie ha contemplato il rispetto del
rinvenuto, l’esigenza di restituire una piena unità formale, senza per questo dare vita ad un falso o
ad un manufatto che non potrà mai più rigenerare ciò che fu messo in opera ab origine, pur nella
consapevolezza della necessità di restituire decoro ad un manufatto di grande significato simbolico,
architettonico e artistico. In tal senso, si intende il restauro come rigorosa pratica di mantenimento
del contesto fisico-materico del costruito, come scienza della conservazione che studia, analizza ed
interviene tempestivamente per arrestare e limitare, combattendone le cause, gli insorgenti
fenomeni di degrado strutturale e materico connessi con un cattivo uso del patrimonio
architettonico. Diventa dunque basilare l’attenzione, il rispetto e la cura per il documento materiale,
per la fabbrica portatrice dei segni del tempo, ispirando il proprio operato affinché non sia sottratta
materia alla fabbrica - per quanto possibile nel rispetto del poco pervenuto già deturpato dall’evento
sismico - ma piuttosto aggiunta con discrezione e facendo crescere la stratificazione storica. Al
progetto di conservazione dell’esistente si associa così, nelle proprie esperienze progettuali e di
cantiere un calcolato progetto del nuovo, come aggiunta autonoma, non mimetica, compatibile e di
qualità.
Monday, September 24, 2012 - 22:00
Monday, September 24, 2012 - 22:00